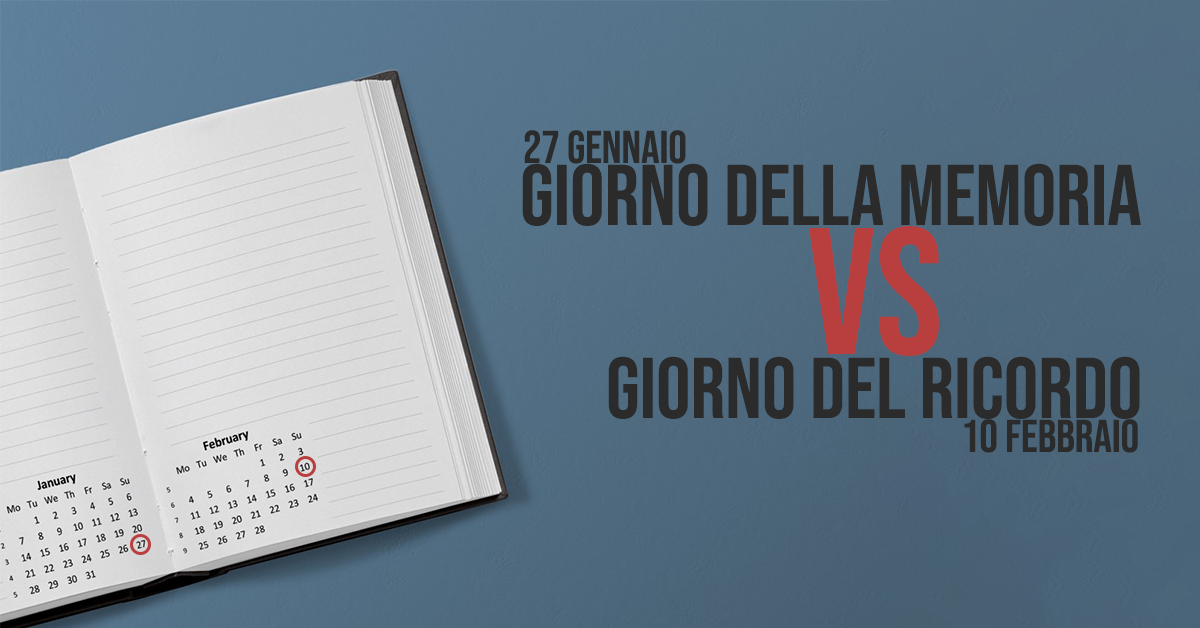La malattia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) è, alla fine, arrivata anche in Italia. Non parlo dei pazienti cinesi ricoverati a Roma già da diverse settimane, ma dei primi casi di contagio locale. Nel momento in cui sto scrivendo i numeri parlano di 232 ammalati, 7 morti e un paziente guarito.
A giudicare dalle reazioni di alcuni giornali e di qualche giornalista, sembrerebbe che una parte del mondo dell’informazione italiana non vedesse l’ora che la malattia colpisse anche il nostro Paese. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un report di inizio febbraio, aveva espresso le proprie preoccupazioni sul rischio di infodemia collegato alla diffusione del nuovo Coronavirus:
The 2019-nCoV outbreak and response has been accompanied by a massive ‘infodemic’ -an over-abundance of information – some accurate and some not – that makes it hard for people to find trustworthy sources and reliable guidance when they need it.
Ciononostante, la ricerca ossessiva di visibilità, attenzione e click non si è arrestata, anzi. Politici e giornali sfruttano la paura del virus per rafforzare la propria propaganda sulle frontiere da chiudere; opinionisti che fino all’altro ieri si occupavano del Festival di Sanremo oggi distribuiscono tweet come se fossero virologi affermati; scienziati dell’ultima ora pubblicano ricette per la preparazione di disinfettanti fai da te. Siamo alle solite, direte voi. Che la disinformazione ormai è una costante nella nostra società, che è normale nell’era della verità post fattuale non riuscire più a distinguere una notizia verificata da una bufala.
Sì, avete ragione, viviamo in tempi complessi dove è difficile orientarsi. Ma permettetemi di aggiungere qualche considerazione. Visto che le notizie false e la cattiva informazione sono apparentemente incontrollabili, quello che possiamo fare è cercare di veicolare il più possibile le notizie vere, attendibili. Ci sono tanti media che lo fanno già (Valigia Blu ha raggruppato tutte le notizie sul nuovo Coronavirus in una pagina, il Post ha creato una newsletter gratuita sul tema). Condividere il loro lavoro è già un ottimo modo per contenere l’infodemia. Anche indignarsi per i titoli di qualche giornale non serve a granché. Siamo d’accordo sul fatto che sia una scelta di pessimo gusto − e non è nemmeno la prima volta che succede − ma in questo caso la soluzione migliore è non comprare quel giornale, preferendo piuttosto testate che hanno deciso di rimuovere le pubblicità sugli articoli relativi al virus, come La Stampa.
Infine, e vi sembrerà banale, potete sempre scegliere di fare silenzio e limitarvi ad ascoltare. Ci sono tanti professionisti qualificati con qualcosa da dire (trovate i loro account Twitter elencati in questa lista): leggete i loro articoli, interagite con loro e sviluppate il vostro pensiero critico a partire dalle loro opinioni. E se pensate di non avere niente da dire, non dite niente.