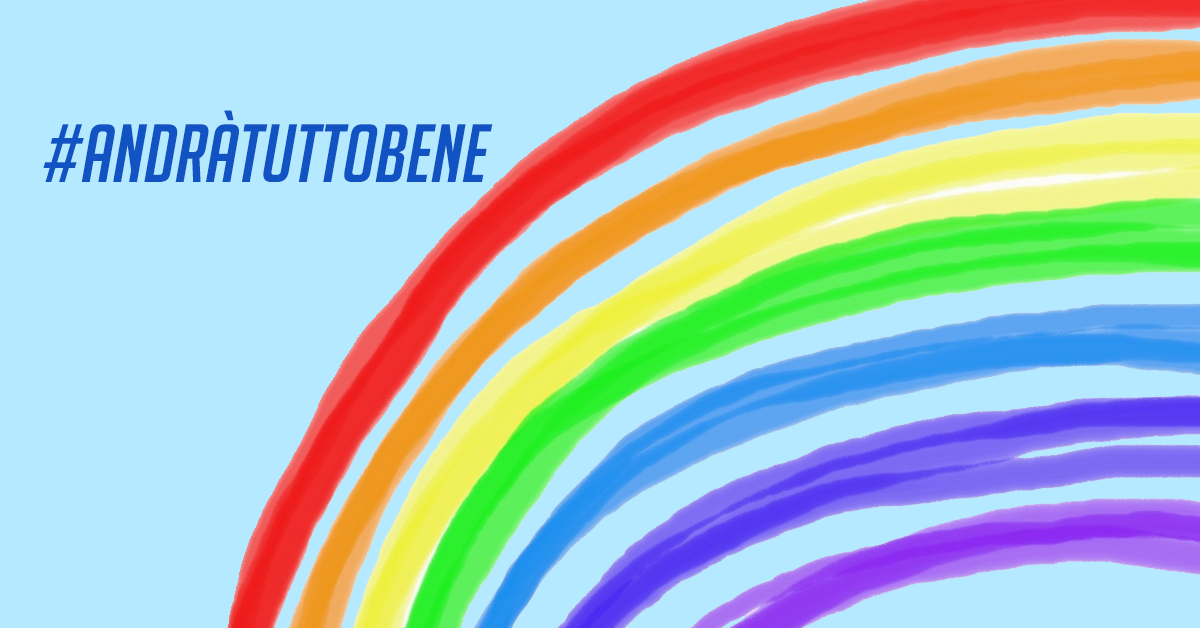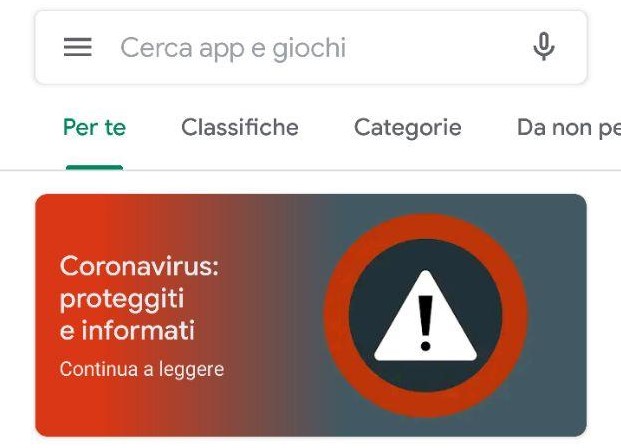Poco fa stavo leggendo questo articolo pubblicato sul New York Times. È una guida che spiega quali attività sarà possibile ricominciare a svolgere regolarmente una volta ricevuto il vaccino contro la COVID–19, e quando. Un passaggio in particolare all’inizio del pezzo ha attirato la mia attenzione:
Because vaccines will not be a ticket back to 2019, Uma Karmarkar, a neuroeconomist at the University of California, San Diego, recommends that people think about “how we are moving forward” instead of “getting back to normal.”
Durante il lockdown in molti invocavano il ritorno “alla normalità” e speravano che le cose tornassero il più velocemente possibile “come prima”. È un atteggiamento comprensibile: ciò che conosciamo, ciò a cui siamo abituati, ci infonde sicurezza e stabilità emotiva. Penso alle conseguenze che ha avuto l’ultima crisi finanziaria sulla nostra percezione della normalità. Quanti imprenditori, quante persone che hanno perso il lavoro e non si sono più riprese vorrebbero, oggi, tornare al 2007?
Settimana scorsa ascoltavo Sebastiano Barisoni – vicedirettore di Radio24 – presentare il suo ultimo libro, Terra incognita (Solferino). Spiegava che una crisi è di per sé un fenomeno transitorio, che può durare più o meno a lungo nel tempo, ma in nessun caso per sempre. Quando invece un evento provoca ricadute profonde sull’assetto stesso della società in cui ha luogo siamo di fronte a qualcosa di diverso: una rivoluzione. Faceva questo ragionamento per dare forza all’idea che quella del 2008 è iniziata sì come crisi economica, ma ben presto si è trasformata in qualcos’altro, qualcosa che ha generato cambiamenti irreversibili, che nessuna nostalgia del passato sarà in grado annullare.
Ho messo sullo stesso piano le considerazioni di Barisoni sull’economia mondiale e l’articolo del NYT sul vaccino perché entrambi gli argomenti offrono, a mio avviso, una chiave di lettura interessante per studiare il desiderio di tornare indietro. E la chiave è: non si torna indietro. Questa affermazione può apparire scontata, ma rappresenta un punto di partenza per definire qual è l’idea di società che abbiamo in mente oltre la pandemia. Il vaccino è il primo passo, ma da solo non è sufficiente.
Ieri l’EMA, l’agenzia europea del farmaco, ha autorizzato ufficialmente la commercializzazione del vaccino contro la COVID–19 prodotto da BioNTech/Pfizer. La campagna vaccinale dovrebbe partire il 27 dicembre, contemporaneamente in tutti gli stati membri. Le raccomandazioni contenute nel pezzo del New York Times si riferiscono a diversi scenari di immunità: personale, famigliare, collettiva. A prescindere da ciò che è considerato o meno sicuro fare in ciascuna di queste fasi, credo che la cosa più importante sia iniziare ora a spiegare alle persone come comportarsi una volta vaccinate, senza aspettare l’inizio della campagna.
Abbiamo visto come reagiscono le persone quando non ricevono indicazioni chiare: interpretano, immaginano, decidono per sé. E lo stiamo rivedendo in queste settimane, quando sui giornali leggiamo del disappunto del Governo perché le persone sono in giro per lo shopping di Natale, dopo che è stata data loro la possibilità di farlo – peraltro introducendo nello stesso momento il cashback di stato, uno strumento economico pensato proprio per favorire i consumi nei negozi.
Le priorità nella comunicazione di una campagna vaccinale non sono i padiglioni a forma di fiore, ma piuttosto dire chiaramente che chi ha ricevuto il vaccino deve continuare a rispettare le regole introdotte in questi mesi, a partire dalla mascherina. Nell’articolo del New York Times che ha stimolato le mie riflessioni si dice, ad un certo punto, che è poco probabile che la vita tornerà a somigliare esattamente al 2019. È importante prendere confidenza oggi con questo concetto, secondo me: prima lo faremo, prima riusciremo ad abituarci ad una società nuova, dove il nostro comportamento dovrà essere, in certi casi, diverso. E sarà più facile abbandonare la frustrazione e il desiderio che le cose tornino come erano prima.